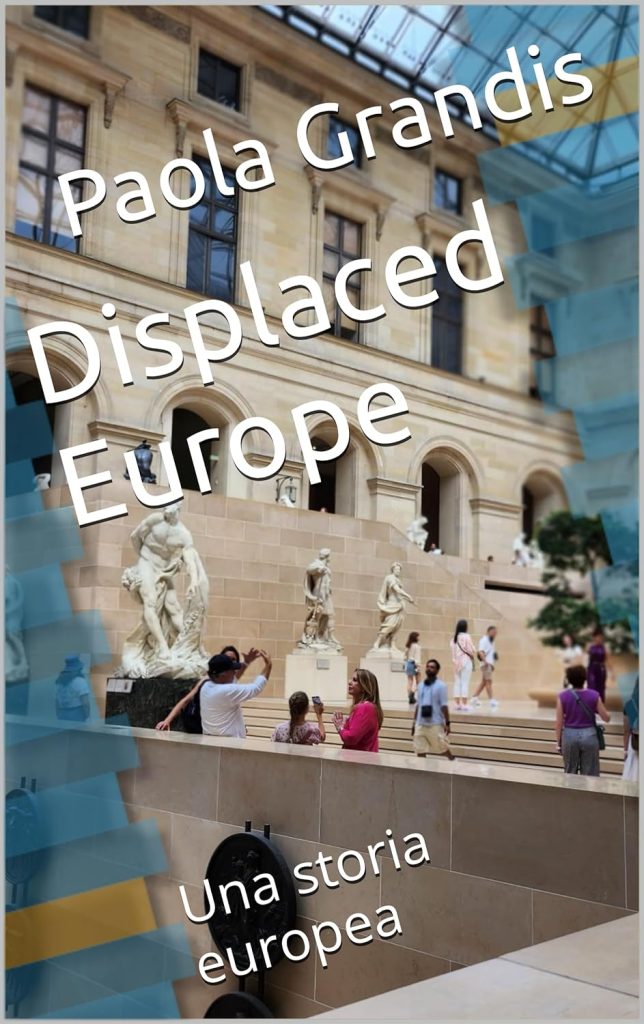Zona grigia
Cos'ho compreso visitando Mauthausen e Gusen
Questa settimana vi porto con me nei ricordi di un viaggio avvenuto qualche anno fa, nel 2015: un viaggio emotivamente molto difficile e provante, che mi ha fatto riconsiderare diverse questioni relative alla seconda Guerra Mondiale e agli orrori dei campi di concentramento.
Quell’anno mi sono recata al campo di Mauthausen e ai tre sottocampi di Gusen, poco distanti dal principale – circa 5 chilometri –.
Non voglio restituirvi un resoconto dettagliato di quanto vidi e appresi all’interno di quei luoghi, lascio questo compito a persone più competenti ed esperte di me.
Vorrei piuttosto riportare in questo blog alcune delle riflessioni che feci quel giorno, su quella che Primo Levi in I sommersi e i salvati definisce la zona grigia e l’omonimo film del 2023 chiama la zona d’interesse: l’oscura collaborazione che gli oppressi, nel tentativo di sopravvivere, sono costretti a instaurare con i loro oppressori.
Arrivo a Mauthausen
Ad accompagnarmi c’erano alcuni miei allievi, altre scolaresche, uno storico, dei colleghi e il nostro mentore di riferimento, un giovane rabbino del luogo. Per arrivare a Mauthausen si attraversano diversi chilometri di pianura e leggera collina, sostanzialmente disabitati per gli standard italiani. Di colpo, un attimo prima di arrivare nel parcheggio sottostante le grandi mura del campo, compaiono una dopo l’altra le maggiori fabbriche tedesche e austriache.
Qui il pullman si ferma e noi scendiamo. Davanti alle mura c’è un campo da pallone.
Subito il rabbino ci racconta delle partite che si tenevano, di cui vedemmo le foto: SS contro internati. Le prime in divisa, i secondi anche: con il pigiama a strisce grigie e blu che purtroppo conosciamo bene. Tutt’intorno il pubblico che osserva e fa il tifo. La sensazione di alienazione che mi aveva colto nel vedere la parata di questi giganti dell’industria edificati in mezzo al nulla e a ridosso di un campo di sterminio, si è ulteriormente rafforzata.
Segue la visita al campo che si conclude con un pranzo in un grazioso ristorante. Dopo quanto visto e provato, apprezzare quell’ottimo pasto non è stato facile. I colleghi e io siamo rimasti silenziosi e timidamente ci siamo confidati su quello che a tutti noi appariva evidente: quella trattoria e l’intero paese si affacciano sul campo e soprattutto sulla Scala della morte.
Ciascuno di noi pensa, senza osare ancora dirlo, che era impossibile non vedere e non sapere. Lo stesso ristorante, inoltre, è chiaramente un edificio dei primi del ‘900 se non addirittura di fine ‘800: non siamo dei grandi esperti di architettura, ma questo riusciamo a capirlo. Dopo il pranzo e prima di ripartire per i tre campi di Gusen, mente i ragazzi si riposano e si riprendono più in fretta di noi, com’è giusto che sia, noi adulti camminiamo con il rabbino e prima timidamente, poi insistentemente, chiediamo.
La zona grigia
Dalla nostra chiacchierata con il rabbino è emerso che, sì, certo che il paese sapeva.
Per quella cittadina l’edificazione del campo ha anzi costituito un vantaggio economico non da poco: sia perché le fabbriche si sono trasferite lì, sia perché il campo stesso, richiedendo una grande quantità di manodopera, forniva lavoro (erano richiesti tutti i settori, dai medici ai maestri, dai sarti e falegnami ai cuochi e al personale addetto alle pulizie).
E sì, anche il ristorante dove ci siamo fermati a pranzo, un tempo, preparava i pasti per i militari nazisti. Il rabbino ci ha spiegato il tutto con una serenità e un atteggiamento zen che ci ha lasciato parecchio perplessi.
Finita la guerra, ha proseguito, c’è stata la grande pacificazione, in tutto il territorio austriaco e tedesco: chi non si era macchiato direttamente di crimini, ha fatto “pubblica ammenda”, scusandosi cioè in pubblica piazza.
Le scuse sono state accettate e, con molto dolore e fatica, si è girata pagina.
Noi adulti italiani, soprattutto in quanto docenti di storia, non sapevamo se essere più ammirati o più stupefatti da queste informazioni.
È stata poi la volta di Gusen, che ci ha riservato non poche sorprese, soprattutto per noi di Torino.
La zona grigia continua a Gusen
Questi sottocampi erano quasi segreti: gli internati, all’interno di grotte e gallerie scavate nelle colline, costruivano armi fondamentali per la guerra (carri armati, blindati e in generale armi di nuova generazione) e per farlo, occorrevano ingegneri e operai specializzati.
Molti di loro erano stati deportati da Torino, dalla FIAT e non erano necessariamente ebrei: chi avesse partecipato agli scioperi indetti dopo l’8 settembre del 1943 o fosse
semplicemente incappato in una retata durante l’occupazione tedesca di Torino e fosse esperto a qualunque titolo in questo tipo di lavorazione – ricordiamoci che anche da noi la FIAT era stata riconvertita alla produzione bellica – finiva a Gusen.
Dopo la permanenza massima di 6 mesi, la morte era inevitabile: da Gusen, vivi non si usciva.
Oggi quelle gallerie e quelle grotte sono state per lo più smantellate e riempite nuovamente di terra. Sulle spianate che ospitavano le intendenze dei diversi campi, hanno costruito dei quartieri residenziali: ai nostri occhi si presentavano giardinetti colmi di biciclette da bambini e palloni da calcio.
Ma in mezzo a tutto questo – e intendo letteralmente in mezzo alle villette, ai giardini e ai giocattoli – c’è un camino con un forno crematorio.
Ovviamente attorno al forno sono presenti in gran quantità fiori, omaggi e ricordi provenienti da ogni parte d’Europa, ma quel camino si è salvato dalla “ristrutturazione” solo grazie ai fondi stanziati dall’Ordine degli Ingegneri di Torino e grazie alla battaglia sostenuta dall’Ordine stesso per impedirne la demolizione.
Ecco. Non aggiungo altro, se non che noi, che la storia l’avevamo studiata e insegnata, dopo quella visita comprendemmo meglio i pericoli insiti una società di massa perfettamente strutturata e incanalata che spesso e volentieri, di non sapere e non vedere, fa soltanto finta, immergendo tutti nella sua zona grigia.
De I sommersi e i salvati – un testo che ho amato moltissimo – vi parlerò in un’altra occasione.